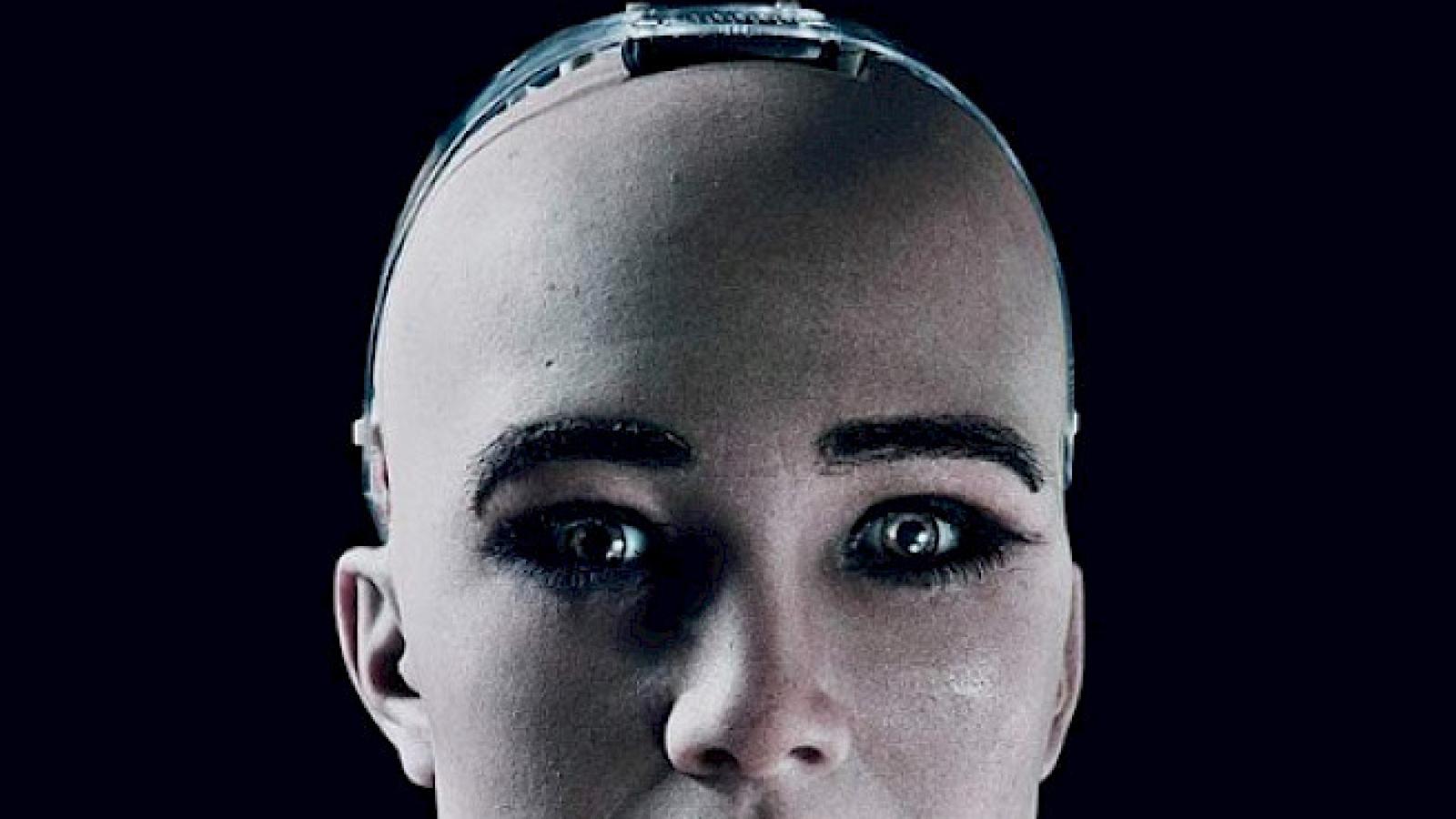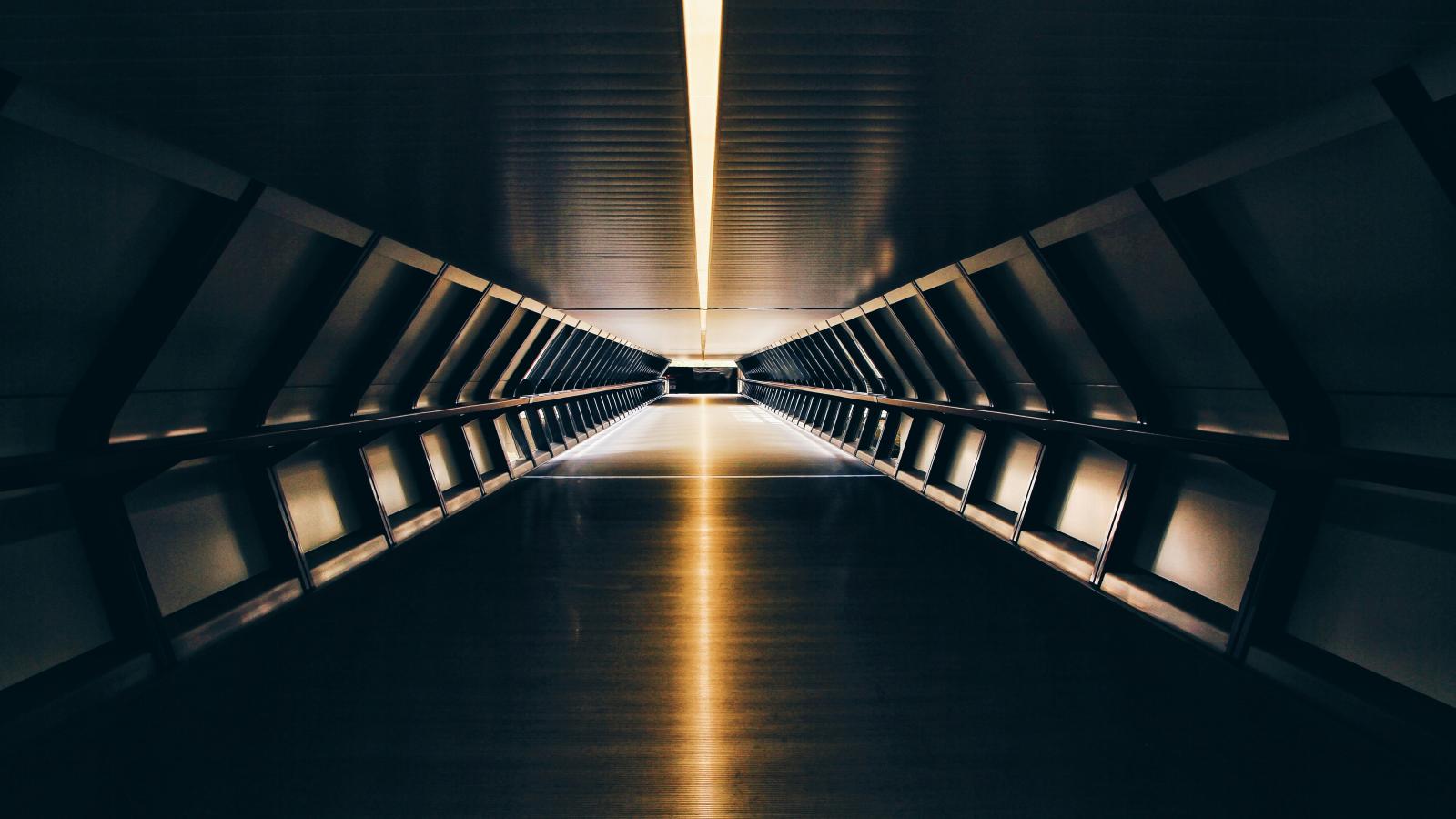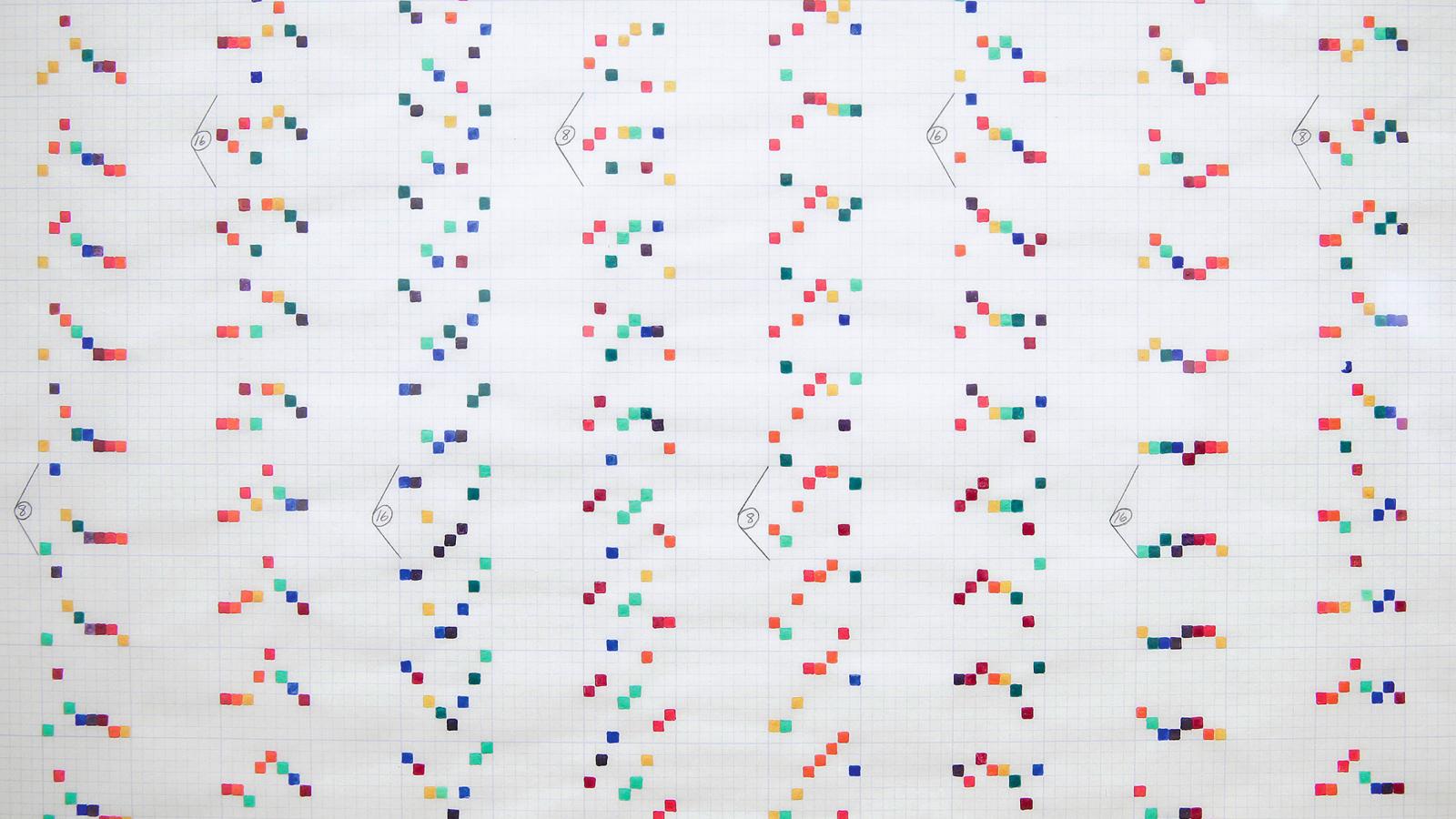La strada delle stelle. Intervista ad Antonio Pennacchi

«I viaggi interstellari sono alle porte! Io faccio il tifo per l’Agenzia Spaziale Italiana. La classe rivoluzionaria non può più essere la classe operaia, ma sarà rappresentata dagli spaziali: nei viaggi sulle astronavi si è costretti a stare uniti, è fondamentale la cooperazione».
Antonio Pennacchi, benché si definisca un “semi-analfabeta digitale”, è un uomo sospeso tra le epoche: da ex operaio a turno notturno in una fabbrica di cavi a isole invita a rivolgere lo sguardo alla conquista dei pianeti resa possibile dalla rivoluzione scientifica contemporanea: «Abbiamo perso i modelli adatti a comprendere la realtà, per questo abbiamo paura. La tecnica porta benessere: genera le bombe atomiche certo, ma anche l’energia nucleare. Senza sviluppo non c’è lotta per l’emancipazione e l’eguaglianza».
Nel suo ultimo libro “La strada del mare” (Mondadori, 2020) racconta la storia della famiglia Peruzzi negli anni Cinquanta, quando nel dopoguerra in Italia arriva il boom economico e si inizia a diffondere la tecnologia di massa. Che Italia era?
Era un’Italia in cui c’era la voglia di darsi da fare, e c’era la consapevolezza diffusa che, se ti fossi impegnato, la situazione tua e di chi ti stava vicino sarebbe sicuramente migliorata. Era forte quel sentimento che Mao Tse-Tung racchiude nella massima “contare sulle proprie forze e lottare con tenacia” e che si legge ancora sulle facce delle persone se ci si reca ad esempio a Tirana in Albania.
E non c’è più nel “bel paese”?
No, non lo vedi più sul volto della gente. È come se questa spinta si fosse esaurita, come se fossimo soddisfatti, saturi, tant’è vero che il lavoro in quanto fine in sé e non semplicemente come mezzo non è più un valore, ma è divenuto un disvalore. Chiediamo il reddito di cittadinanza: i soldi, non il lavoro. Si pensa di doversi liberare dal lavoro invece che attraverso il lavoro. L’uomo però rimane homo faber: chi sei se non produci, se non fai qualcosa?
Che cosa è accaduto?
Negli anni Cinquanta venivamo da una guerra che aveva distrutto il paese, e con la caduta del fascismo le larghe masse popolari avevano conosciuto finalmente, dopo secoli di oppressione, la libertà. Ora il processo involutivo ha travolto l’Italia e le diseguaglianze sono ormai palesi e insostenibili: perché devo andare a
lavorare in campagna a tre euro l’ora se ci sono i ricchi per nascita che sono sempre più ricchi e continuano a comandare? Non cambia mai nulla? Siamo ancora a questo punto?
Lei si è sempre definito un “egualitarista assoluto”. Come interpreta la lotta per il superamento delle diseguaglianze?
Io ho attraversato diverse fasi nella mia vita. Il ’68 ha cambiato tutto. All’inizio ho creduto anche all’ipotesi rivoluzionaria di ribaltare il sistema, di costruire una dittatura del proletariato. Poi ho avuto la convinzione che la nostra fosse una democrazia progressiva, che si potessero modificare i rapporti di forza e stavo dentro al movimento operaio perché credevo di contribuire con gli altri alla costruzione della linea politica. Negli anni Settanta lottavo per la democrazia in fabbrica, per la gestione della fabbrica: pensavo fosse nostra, non del padrone, ritenevo che le volessimo più bene noi operai. Volevamo partecipare ai processi decisionali. E all’epoca dei risultati li abbiamo ottenuti. Non abbiamo fatto la rivoluzione, ma l’Italia del dopoguerra si è rialzata e dacché era uno dei paesi più poveri al mondo, privo di materie prime, è divenuta la sesta economia del pianeta. In quell’Italia di fatto c’era la socialdemocrazia, c’era una grande attenzione ai diritti dei lavoratori. È chiaro, la lotta tra i poteri forti e le masse proletarie è stata spietata, la polizia sparava, abbiamo avuto la strategia della tensione, le bombe…
Un mondo che non esiste più, come non esiste più la classe operaia.
È certamente cambiato il suo peso specifico all’interno della società perché si sono modificate le forme della produzione. Gli operai sono sempre più specializzati, ma il tema delle garanzie sociali e dei salari rimane. Bisogna proteggere anche chi porta i pacchi in giro, le badanti che curano i nostri anziani: i più deboli. Il bisogno di socialismo nel mondo non si è esaurito, è anzi più forte di prima. Le multinazionali hanno fatto casino: la precarizzazione del lavoro è legata anche alla totale assenza di controllo da parte della politica nei confronti dei grandi gruppi capitalistici. Il tema è quello di un governo mondiale che affronti il problema del lavoro a livello internazionale, oltre che il rapporto tra le masse e i centri decisionali. Occorrono i sindacati mondiali dei lavoratori. Il capitalismo finanziario non può continuare ad agire indisturbato.
La globalizzazione contemporanea è l’unione del capitalismo e dell’apparato tecnico-scientifico. Ritiene dunque che si debba lottare contro questa iper-connessione globale?
La globalizzazione, frutto della civiltà dell’informazione, può avere prodotto tanti problemi, però anche un fatto: in meno di trent’anni ha portato miliardi di esseri umani dalla fame, dalla preistoria, al benessere. O pensiamo che il benessere sia un diritto solo europeo e occidentale? È in atto un avanzamento straordinario.
Tutto il patrimonio culturale della nostra civiltà pesa sulle spalle di poche migliaia di persone nel corso di tutta la storia. Oggi miliardi di individui usano il computer, di questi gran parte scrive solo cazzate, ma tanti altri leggono, studiano, comunicano. Quindi se grazie a pochi siamo arrivati alle navicelle spaziali tra vent’anni dove potremo essere con tutte queste persone che pensano e studiano? La globalizzazione ha allargato all’ennesima potenza i pozzi della sapienza.

(In copertina) Evocation, Shirin Abedinirad, 2013, installazione di land art realizzata nel deserto centrale iraniano. (Sopra) Braccio meccanico esegue saldature su componenti metallici coadiuvato da un operaio, foto di BigBlueStudio
Non pensa che la progressiva meccanizzazione del lavoro rischi di togliere spazio all’umano? Che i robot rendano superflua l’azione dell’uomo?
Io credo che la tecnica renda spazio all’umano. Non sta scritto da nessuna parte che al lavoro debbano corrispondere per forza la fatica, il sudore e il sangue, e che si debba lavorare 16 ore al giorno. Keynes diceva che il progresso scientifico avrebbe portato a una società dove non sarebbe stato necessario lavorare 8 ore al giorno, ma sarebbe stato sufficiente lavorarne 4. Si riduce il lavoro necessario: se produci ricchezza con le macchine produci di più, e se ridistribuisci questa ricchezza allora va tutto bene, ma se non lo fai e va tutto nelle mani di uno solo, allora il plusvalore prodotto diventa un problema. In ogni caso ritengo che lo spazio della manifattura resterà sempre perché ci vuole chi ripara i robot. Inventeremo robot in grado di riparare altri robot? Se sarà così, vorrà dire che lo spazio dell’uomo si amplierà in altri modi, e se saremo in grado di costruire un’intelligenza artificiale che potrà fare completamente a meno di noi allora ancora meglio: questa sarà la nostra sublimazione, diventeremo purissimo spirito.
Ma noi siamo fatti di carne, e non la possiamo abbandonare!
Più la abbandoniamo e meglio è! Noi qui siamo un misto di carne e di luce, ma probabilmente il compito che ci è stato assegnato è far prevalere la luce.
E con la robotizzazione non si corre il rischio di abbandonare una vita più autentica? Di uno sradicamento?
Ma cosa vuol dire? Studiare con i libri di carta, prodotti anch’essi dalla tecnica, è allontanarsi dal reale? Il processo della civilizzazione umana è strettamente legato al progresso tecnologico e scientifico, è un dato di fatto. Spesso si sente dire che tra progresso morale e sociale e progresso tecnico-scientifico non c’è corrispondenza, che mangiamo di più e meglio, ma che questo non ci rende migliori. È falso. E ci sono degli indicatori che lo testimoniano: il tasso di violenza e di guerra. Certo, la nostra società è ancora violenta perché il bene e il male vivono dentro di noi, nei nostri istinti più bestiali. Ma già a partire dall’homo sapiens abbiamo tracce di sepolture e di una socializzazione operata attraverso la costruzione di oggetti: costruire uno strumento vuol dire trasmettere un sapere. Quella che chiamiamo civilizzazione ha circa 8000 anni, è sostanzialmente appena iniziata. Il livello dei tassi che ho indicato era infinitamente più elevato rispetto ad adesso: ad esempio, il primo straniero che si affacciava sul territorio di caccia veniva ammazzato perché metteva in discussione la sopravvivenza della propria famiglia, e una volta catturato il nemico era normale torturarlo. Ora non accade quasi più.
Non le pare una visione di cieco fideismo nel progresso?
L’età dell’oro sta sempre davanti, non dietro, la storia procede verso il meglio. Io non so come le cose stiano nell’aldilà, nella metafisica. Quello che so è che io sto qua e mi rifiuto di credere che questo non abbia un senso. Il senso del mio esistere risiede nella storia e glielo conferisco io cercandomi nella assoluta identità con gli altri. Una consapevolezza sola mi è rimasta: ogni avventura umana è assolutamente uguale a quella di tutti gli altri. Le infinite irripetibilità delle nostre storie concorrono alla formazione di un’unica identità umana nel tempo e nello spazio. Esiste un passo evolutivo della storia che si sviluppa come una spirale senza fine, lento, non misurabile sulla distanza della singola esistenza umana, ma tra le generazioni.
La sua vita le ha testimoniato in un qualche modo questo avanzamento?
La fabbrica ti insegnava che il pezzo che costruisci tu deve essere fatto bene perché altrimenti chi arriva dopo di te non riesce a montarlo: ti mostrava che il tuo lavoro è legato a quello degli altri. Ognuno di noi non è che un portatore di mattoni, un tramite nell’arco delle generazioni. Spesso si dice che non c’è più differenza tra destra e sinistra: sono cazzate. Per me la differenza sta soprattutto nella dicotomia tra competizione e cooperazione, tra individualismo e collettivismo. Tra un’idea del mondo che vede risolversi tutto nell’io e di cui il mondo è emanazione, e una che capisce che l’unico modo di cercare sé stessi è negli altri, stare con gli altri. Il modello americano è basato sulla competizione, a me quello che la fabbrica ha insegnato è la cooperazione. E credo non ci siano altre possibilità per l’umanità: la fratellanza, la solidarietà, questo è il socialismo. Dio per potersi risvegliare ha bisogno del socialismo perché solo noi possiamo costruire qui in Terra la città di Dio grazie alla civilizzazione.
Leggi anche
"La valle oscura": vivere e morire nella Silicon Valley
Da tempo ormai la Silicon Valley è al centro delle attenzioni, spesso ossessive, di opinione pubblica, intellettuali, politici e semplici curiosi.
150 anni di Marconi: il primo imprenditore globale dell’innovazione
Elettra Marconi racconta il padre e la nave laboratorio che porta il suo nome: a bordo dello yacht Elettra l’inventore della radio ha girato il mondo compiendo straordinari esperimenti
5G, la tecnologia plasma il futuro: l'umanità è un'appendice superflua
Gli spot sulla nuova rete internet sono il manifesto dell'ideologia tecnocratica: la fantascienza è già scienza.
Ambivalenza o equivalenza
Se in una chat attribuite umanità al vostro interlocutore, e questi si rivela una macchina, allora si tratta di una macchina intelligente. Un’intelligenza artificiale.