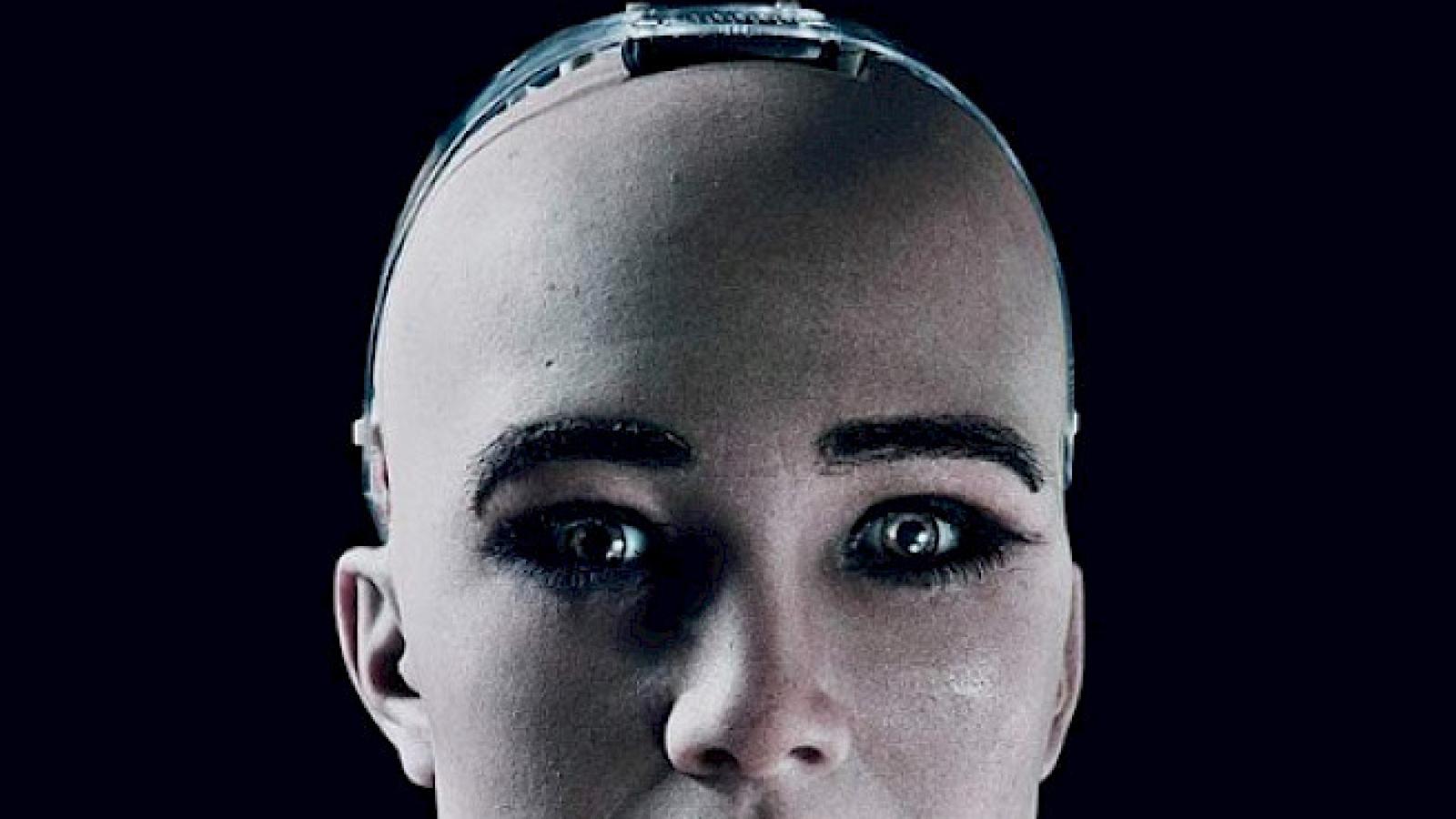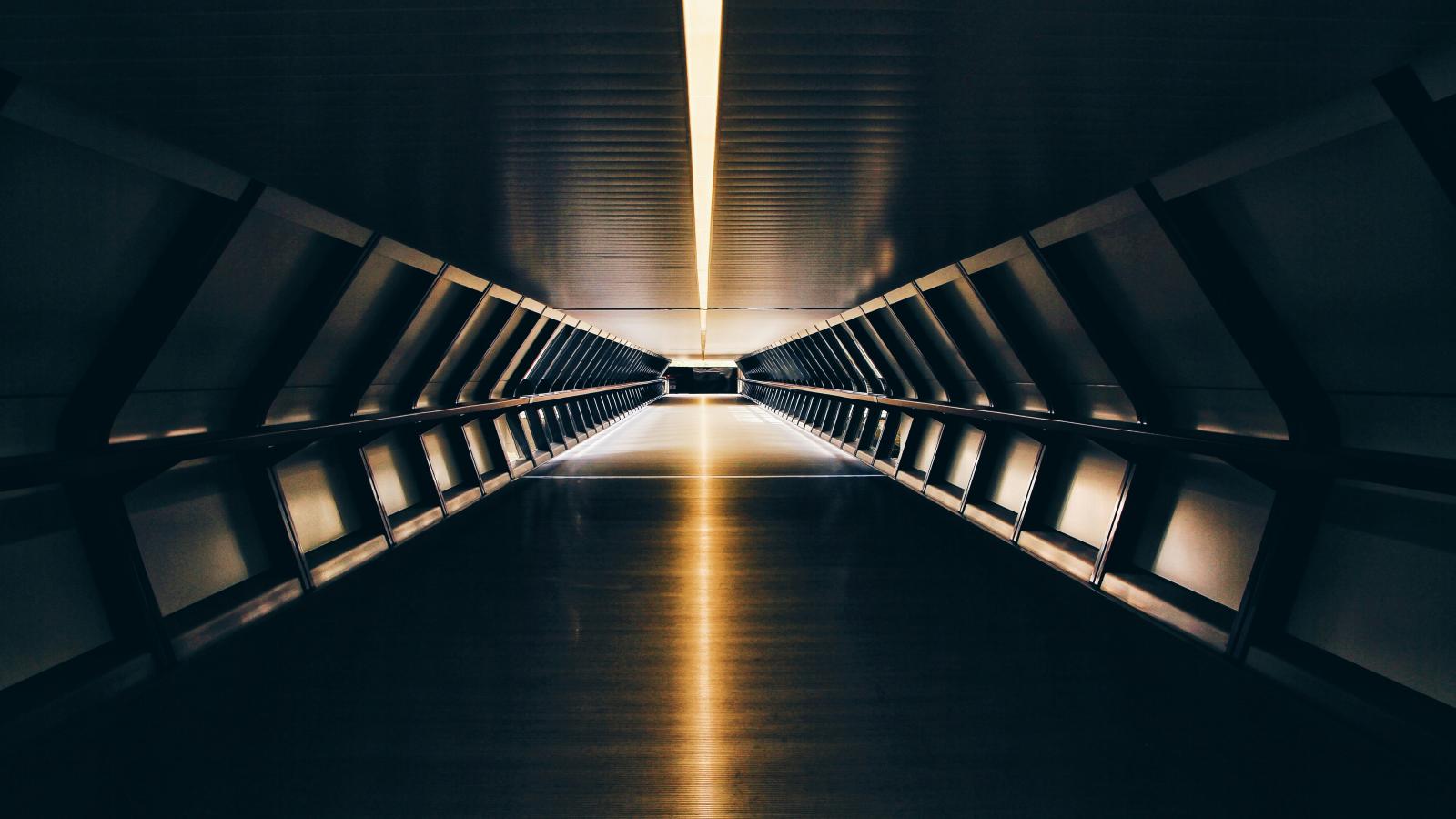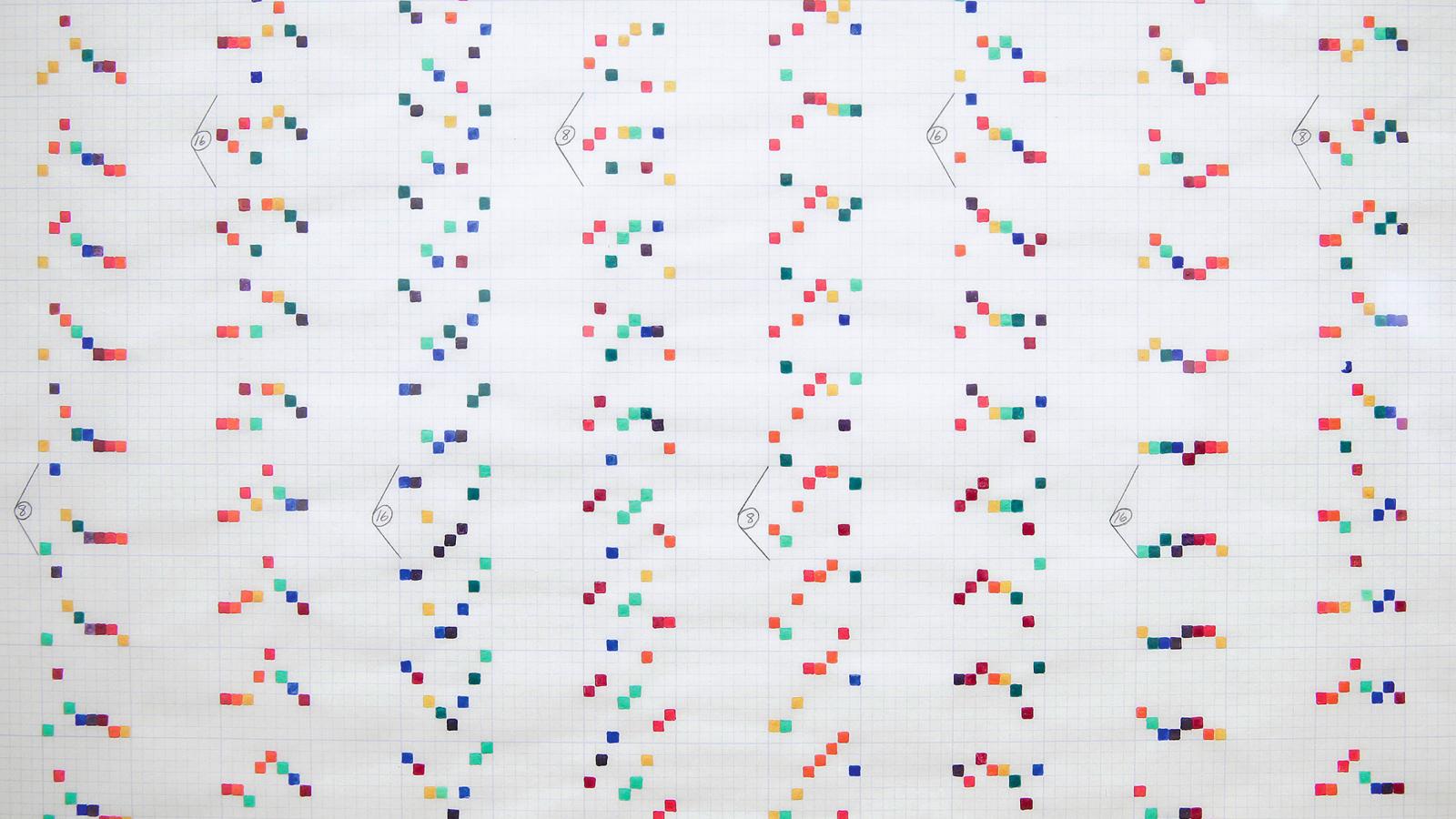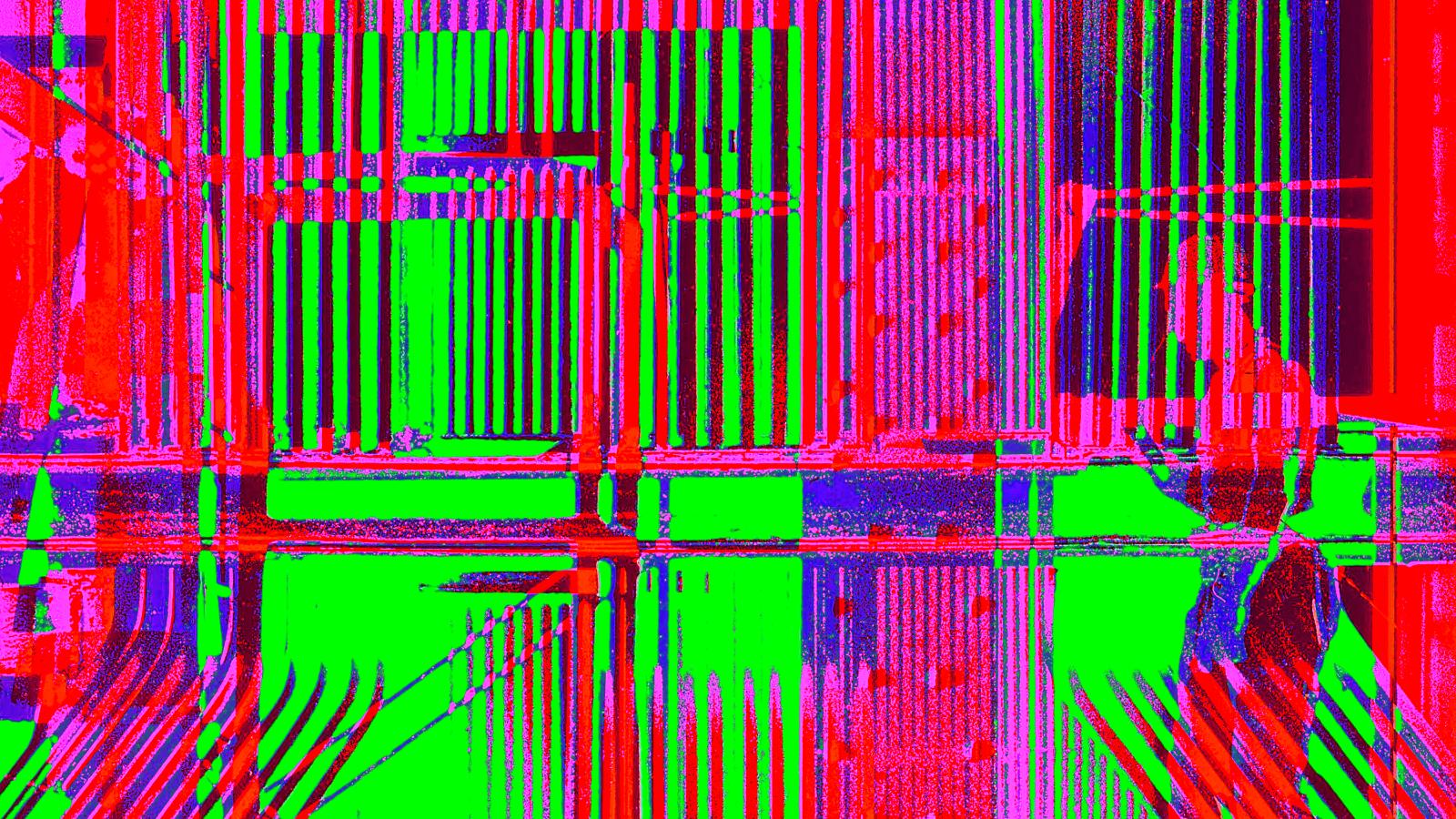Quando l'argine si rompe. Conversazione con Paolo Giordano

«Il 5G? Non sono ancora abbastanza informato, ma mi divertono i complottismi che si sono già “appiccicati” a una tecnologia di cui sappiamo ancora così poco. La prospettiva di un’incessante connessione, tuttavia, non mi entusiasma ma nemmeno mi spaventa, anzi mi dà una certa sicurezza. Perché in fondo convivo con l’atavica paura di perdermi nel bosco».
Della paura e di ciò che ne consegue Paolo Giordano, un dottorato in Fisica teorica e un Premio Strega vinto con “La solitudine dei numeri primi” (Mondadori, 2008), è stato tra i primi narratori, mentre montava l’onda di Sars-CoV-2: suoi una serie di articoli pubblicati sul “Corriere della Sera” e il pamphlet “Nel contagio”, uscito per Einaudi in eBook in primavera, quando intorno tutto era chiuso e incredulo.
“Civiltà delle Macchine” lo incontra – alla fine di ottobre – nell’incertezza di una seconda ondata, di una seconda stretta, mentre la cronaca scrive in fretta la storia, e l’Italia torna a rincorrere i bollettini. Nelle analisi di Giordano, matematiche e insieme divulgative, il diffondersi della pandemia diventa imprevista metafora di una interconnessione totale e totalizzante, tale che «se gli esseri umani fossero uniti tutti con un tratto di penna, il mondo sarebbe un unico scarabocchio»: a ciò si deve la ricaduta della singola azione individuale su conseguenze globali.
In questo inestricabile groviglio si dipana una globalizzazione materiale – quale è quella epidemica – e una digitale, fatta di connessioni costanti e stabili: quelle del 5G. È una prospettiva che apre più possibilità di libertà o che costringe alla costante reperibilità?
A guardare la mia vita non cambierà molto, temo di essere già costantemente connesso. Conto sulla punta delle dita le esperienze significative di disconnessione degli ultimi anni. La pervasività delle tecnologie e della multimedialità nelle nostre vite non è una cosa di cui io sia particolarmente entusiasta, ma non mi preoccupo troppo di una iper-connessione. Ho l’impressione che se uno vorrà disconnettersi lo potrà fare: ci sarà sempre un modo, anche se magari sarà un po’ più faticoso e meno naturale. Ma si troverà un modo per “isolarsi”, se lo si ritiene opportuno e sano. Sono però molto preoccupato da tutti gli aspetti che riguardano qualcosa che possiamo chiamare “capitalismo della sorveglianza”.
Cosa intende?
È il titolo di un’opera della professoressa Shoshana Zuboff che analizza il modo in cui l’uso dei nostri dati da parte dell’universo di internet, di Google e di Facebook ci mette davanti a una nuova frontiera piuttosto allarmante del capitalismo. Lei analizza il dettaglio, i modi di estrazione di informazione e di valore delle nostre abitudini quando siamo on-line: i dati stessi sono il valore, le nostre vite lo sono, e siamo noi a fornirli. In un pezzo uscito a febbraio su “La Lettura” ne elencavo i rischi: il targeted advertising a scopi commerciali ed elettorali, la psicologia del comportamento, la progressiva perdita della privacy, fino alla presenza di elettrodomestici capaci di memorizzare dati registrati in casa. Il tema della tracciabilità dei dati è molto legato anche ai dubbi che sono stati avanzati durante questa pandemia, quando si trattava di mettere a punto l’app Immuni, dubbi che hanno portato poi a una serie di scelte che hanno reso di fatto inefficace uno strumento di cui in realtà avremmo molto bisogno. È un argomento complesso.
Rientriamo dunque nel tema pandemia.
Non ne siamo mai usciti. È il tempo il concetto chiave in questa fase: è curvato dal contagio. In una crescita non lineare come quella che caratterizza naturalmente lo svolgersi di una epidemia, soprattutto quando va fuori controllo, i giorni che si susseguono non hanno tutti lo stesso valore, ma pesano di più man mano che si va avanti. Ogni giorno si porta un carico maggiore del precedente in termini di contagiati, di ricoverati e dunque di morti, seguendo una progressione – possiamo usare il termine – esponenziale: tutto diventa più grave, più decisivo. Col passare dei giorni aumentano la sproporzione e la velocità.
Dove abbiamo sbagliato?
L’errore è stato tergiversare quando abbiamo capito che la ripresa del contagio era di nuovo accelerata, ma il primo sbaglio è stato non attrezzarci quando ne avremmo avuto il tempo: sono mancate sia la prevenzione che la tempestività. La sorpresa più amara di questo settembre è stata la sbalorditiva velocità con cui sembriamo aver dimenticato il pericolo, i sacrifici, i rischi del contagio: l’allentamento della scorsa estate. L’essere umano è portato alla rimozione dei ricordi dolorosi, lo sappiamo, ma in questo caso sembrava che ci fossimo lasciati tutto alle spalle, essendoci ancora completamente dentro. La rimozione non nel post, ma nel durante: questa è stata una novità. A rivelarsi fragile è stata poi tutta la struttura di monitoraggio e di assorbimento.
In proposito parla di tipping-point come del punto in cui l’argine si rompe, ed esonda la piena. Non esiste la possibilità di prevederlo?
Quando ne ho parlato, a ottobre, eravamo già lì, io ne scrivevo come di una cosa da scongiurare, ma eravamo probabilmente già oltre il punto di rottura. L’intento di chi scrive non è quello di recriminare, ma quello di spingere all’azione. C’è stata una sottovalutazione grossolana: questa sensazione di essere fuori dall’epidemia è stata una scivolata grave, in generale. È mancata la comprensione dei cambiamenti a lungo termine. Abbiamo la possibilità di far sì che questi mutamenti non avvengano malgrado noi: sarebbe questa la vera missione anche della politica, al di là della gestione del dramma. Siamo viziati da anni di pensiero a corto raggio, e questo è un tipo di pensiero che non può che fallire. Bisogna avere un pensiero più ampio, anche se magari non troppo. Io ad esempio ragiono sempre togliendo il vaccino dal quadro, perché non sappiamo quando arriverà, e finché non c’è è un dato di speranza che vizia il discorso, ci porta nel pensiero magico.

(Copertina) L’Attesa, foto di Paola Gareri, Sicilia, 1989. (Sopra) Promenade, Davide Quayola, 2018, video
Crede che il racconto, il modo in cui l’informazione sul Covid-19 è stata data e affrontata, abbia potuto sbilanciare anche la maniera in cui è stata poi percepita la verità scientifica?
Senz’altro. Il problema è che continuiamo a comunicare le notizie nel modo in cui eravamo abituati a farlo prima. Quasi tutti i problemi che riguardano la gestione dell’epidemia sono temi che riguardano il prima, e che semplicemente vengono resi evidenti e aggravati dalla situazione. Ma la comunicazione è andata sempre più nella direzione della ricerca dell’emotività al di sopra di tutto. In un momento in cui ciò di cui si ha bisogno è invece comprensione, ragionevolezza e misura, è chiaro che così è difficile ripararsi. Questo ha portato delle conseguenze specifiche: pur di salvare il contraddittorio rabbioso a cui siamo abituati in televisione spesso è stato dato spazio a delle opinioni pseudo-scientifiche che tuttavia hanno pesato nell’opinione pubblica che in quel momento era molto fragile. Proprio il 5G, ad esempio, è stato indicato da alcuni come veicolo di contagio del Covid-19, non so con quali argomenti.
È il rischio della parresia, la libertà di parola. La conoscenza è proporzionale alla democrazia?
No. Il pensiero che la conoscenza diffusa sia una via automatica verso la democrazia è infondato. Gli studi evidenziano che siamo tutti suscettibili alle teorie del complotto, senza differenze di istruzione, reddito, genere. È un falso mito, l’idea che sia una questione di ignoranza. Anzi, io trovo che nella scienza lasciata a sé, cioè non corretta da un pensiero più ampio, ci sia il rischio del totalitarismo. A proposito della divulgazione, c’è invece un altro tema: negli scorsi mesi abbiamo assistito a quanto pur vivendo in un mondo che è completamente modellato da scienza e tecnologia, ci sia stata una difficoltà evidente nel comunicare tutto ciò che riguarda la scienza. Mi sembra che la comunicazione sia stata uno dei disastri più conclamati in questa pandemia, e molto ha a che fare con l’essere sguarniti proprio lì dove si doveva creare un ponte tra le persone e chi ha dei saperi specifici. È un dialogo di cui avremmo bisogno.
È il tema del dialogo tra le due culture. Dove si interrompe, dov’è che scienza e umanesimo non si parlano?
Con la crescita esponenziale che hanno avuto i saperi scientifici nel Novecento abbiamo assistito a una iper-specializzazione. La conseguenza si vede nel sistema dell’istruzione che porta a eliminare troppo presto dal proprio percorso di studi certi argomenti in base a una suddivisone per materie: è a scuola che avvengono le separazioni, non – come ci fanno pensare – nell’anima delle persone. Mentre per Goethe era possibile essere uno scrittore e un pensatore ad ampio raggio, oggi le zone del sapere che ti sono precluse sono la maggior parte. Le faccio un esempio. Durante l’ultimo anno di università, dopo aver preparato tutti gli esami del corso di studi insieme a due amici, scoprii che solo un paio di settimane dall’avvio del lavoro per le rispettive tesi non eravamo già più in grado di spiegarci a vicenda che cosa stessimo studiando. Questo è il grado di specializzazione in cui le scienze si trovano.
Tornando “nel contagio”: qual è oggi l’orizzonte?
La fine dell’inverno è l’orizzonte. Abbiamo davanti mesi molto lunghi: vanno fatte scelte di investimento ragionevole, anche considerando le energie del paese.
E lei ha ancora paura che lo spavento passi senza lasciarci un cambiamento, più ancora che del contagio in sé, come aveva scritto all’inizio di questa vicenda?
No, adesso ho più paura di ammalarmi di quanta ne avessi allora: era il 29 febbraio quando iniziai a scriverne. Ora che ne sappiamo di più, siamo stati portati a derubricarla come uno scampato pericolo: io invece ne ho più timore oggi.
Leggi anche
"La valle oscura": vivere e morire nella Silicon Valley
Da tempo ormai la Silicon Valley è al centro delle attenzioni, spesso ossessive, di opinione pubblica, intellettuali, politici e semplici curiosi.
5G, la tecnologia plasma il futuro: l'umanità è un'appendice superflua
Gli spot sulla nuova rete internet sono il manifesto dell'ideologia tecnocratica: la fantascienza è già scienza.
Ambivalenza o equivalenza
Se in una chat attribuite umanità al vostro interlocutore, e questi si rivela una macchina, allora si tratta di una macchina intelligente. Un’intelligenza artificiale.
Astronavi sulle spighe
Peppino Caldarola – già redattore presso il catalogo Laterza, due volte a capo de “l’Unità”, direttore di “Civiltà delle Macchine” – è stato un comunista.